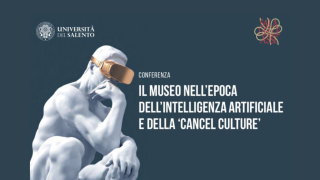C’è un luogo che in realtà è un non luogo che esiste oltre l’apparente trasparenza della rete, dove le regole del web tradizionale cessano di esistere e anonimato e pericolo si intrecciano in un grottesco tango. È il dark web, la quarta dimensione digitale, sempre più spesso citato nei casi di cronaca nera e nelle narrazioni popolari come regno in cui si muovono trafficanti, sicari, pervertiti di ogni genere, una sorta di immenso mercato nero dove è possibile trovare tutto ciò che la mente umana può immaginare.
Una sorta di girone dantesco teatro di storie al limite del credibile, una zona franca della rete, dove circolano dati rubati, armi, droghe e persino servizi di omicidi su commissione. Altri, più sobriamente, lo considerano uno spazio necessario per il dissenso politico e la libertà d’espressione in contesti repressivi.
La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Ed è proprio questo dualismo che rende il dark web un fenomeno affascinante e respingente al tempo stesso: da un lato strumento di sopravvivenza digitale per chi rischia la vita nei regimi autoritari, dall’altro, rifugio virtuale per attività criminali che sfuggono alle maglie della giustizia tradizionale.
In poche parole, il dark web è una parte del deep web, cioè quella porzione di internet non indicizzata dai motori di ricerca tradizionali a cui si accede tramite l’installazione di software specifici, come ad esempio Tor, che garantiscono l’anonimato degli utenti.
In realtà, molte delle storie che circolano sul dark web, sono davvero leggende metropolitane. Ad esempio delle red room, stanze virtuali dove si assisterebbe a torture o omicidi in diretta streaming della cui esistenza non si hanno prove certe, tanto che si suppone si tratti più che altro di truffe finalizzate all’estorsione di denaro.
Un altro mito racconta della presenza di sicari che possono essere assoldati per uccidere, ma anche in questo caso, sembra si tratti per lo più di truffe, perché una volta siglato l’accordo e versato il denaro, il servizio non viene portato a termine
Ma al di là delle leggende, è davvero teatro di crimini reali e gravi. Uno dei casi più noti è quello di Peter Scully, un australiano condannato all’ergastolo per aver gestito un sito di pornografia infantile dove venivano condivisi video di abusi su minori, o anche Silk Road, un mercato nero online dove si potevano acquistare droghe, armi e altri beni illegali, chiuso nel 2013, mentre il suo fondatore, Ross Ulbricht, è stato condannato all’ergastolo.
Il dark web è anche un mercato fiorente per dati rubati. Secondo un report di Kaspersky, ogni mese vengono pubblicati in media 1.700 post contenenti dati aziendali compromessi utilizzati per accedere illegalmente a infrastrutture aziendali.
Secondo Tinexta Cyber, tra il 2017 e il 2020, le operazioni su queste piattaforme sono cresciute del 300%, e si prevede che entro il 2028 il mercato globale raggiungerà 1,3 miliardi di dollari. Tra i prodotti più venduti ci sono malware, ransomware e dati rubati. Le criptovalute, come il Bitcoin, sono il mezzo di pagamento preferito, garantendo un alto livello di anonimato.
In Italia, nel 2021, un uomo è stato arrestato per aver cercato di ingaggiare un sicario sul dark web con l’obiettivo di sfregiare la sua ex fidanzata. L’uomo aveva pattuito un pagamento di 10.000 euro in Bitcoin.
Nel maggio 2023, l’operazione internazionale SpecTor ha portato all’arresto di 288 persone in nove Paesi, tra cui l’Italia. L’indagine ha smantellato la piattaforma illegale Monopoly Market, sequestrando 850 kg di droga, 117 armi da fuoco e 51 milioni di euro in contanti e criptovalute. Pochi mesi dopo, un attacco hacker ha colpito un’azienda sanitaria italiana, con la pubblicazione sul dark web di 1.000 gigabyte di dati sensibili, comprese cartelle cliniche. Gli hacker avevano richiesto un riscatto di 3 milioni di dollari in criptovalute, minacciando la diffusione dei dati in caso di mancato pagamento.
Un’analisi del 2024 ha rivelato che circa 3.300 utenti di siti pedopornografici sono stati smascherati grazie a malware che rubano informazioni, un dato importante, perché ha dimostrato come evidenzia le tecnologie utilizzate per proteggere l’anonimato possano essere sfruttate anche per identificare i criminali
Nel febbraio 2025, un’operazione congiunta della Guardia di Finanza italiana, Europol e polizia spagnola ha smantellato una rete criminale che operava tra il dark web e Telegram vendendo banconote false, documenti contraffatti e droga, utilizzando criptovalute come metodo di pagamento. L’operazione ha portato a tre arresti, all’oscuramento di 11 canali Telegram e al sequestro di 115.000 euro, inclusi fondi in criptovalute come Dogecoin.
Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha rivelato che circa il 5% degli studenti delle scuole medie ha già avuto accesso al dark web, in alcuni casi, i giovani utilizzano piattaforme come Telegram per condividere esperienze con armi o costruire ordigni.
Il dark web rimane dunque un crocevia ambiguo e sfuggente, dove convivono libertà e orrore, dissenso e crimine, mito e realtà, un territorio che, più di ogni altro, riflette le contraddizioni della natura umana, che può costruire spazi di resistenza contro l’oppressione e allo stesso tempo spalancare voragini oscure dove si consumano atrocità indicibili.
Ciò che davvero dovrebbe inquietare non è tanto l’esistenza di angoli remoti della rete, quanto il fatto che, a ogni leggenda metropolitana che viene smascherata, corrispondano vicende reali che superano di gran lunga l’immaginazione. La sfida non è eliminare il dark web, impresa impossibile per definizione, ma sviluppare strumenti, cultura digitale e consapevolezza sociale capaci di riconoscerne i rischi, sfruttarne le potenzialità etiche e contrastarne le derive più abiette.
Il dark web è il riflesso distorto di una società che, mentre predica trasparenza e sicurezza, alimenta in silenzio i propri incubi più profondi. Non è il regno di pochi deviati nascosti dietro schermi e criptovalute, ma il prodotto di un’umanità che, quando crede di non essere vista, mostra il suo vero volto.
La domanda che bisognerebbe porsi infatti, non è cosa si nasconda nel dark web, ma perché esistano milioni di persone disposte a cercare, vendere, pagare e guardare ciò che offre alimentando una creazione umana, il naturale prodotto collaterale di una società che, dietro la facciata di progresso e civiltà, conserva appetiti antichi quanto il mondo.